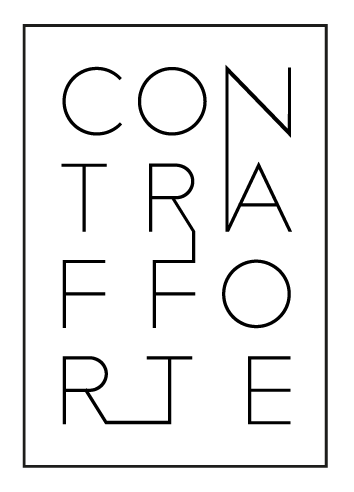Parlava il tedesco padre Luigi Szenik, era un salesiano e faceva la guida alle Catacombe di San Callisto. Parlava il tedesco, quindi capì ciò che farneticavano quei due SS e improvvisamente si mise a correre a perdi fiato con alcuni suoi confratelli; si intrufolarono in quei cunicoli e, facendosi largo tra passaggi che solo loro conoscevano, si trovarono davanti l’orrore.
Per mesi centinaia di famiglie romane vissero nella disperazione. Sapevano, ormai rassegnati, che quei loro parenti arrestati la sera del 23 marzo erano stati assassinati, ma ciò che li preoccupava ora era capire dove fossero sepolti i loro corpi. Nessuno ne aveva idea. C’erano in giro strane voci e lo strazio era diventato ormai insopportabile. All’indomani della liberazione di Roma avvenuta il giugno successivo i frati salesiani contattarono finalmente le autorità Alleate per avvertirle di ciò che padre Szenik aveva scoperto quella sera: laggiù lungo l’Ardeatina, all’altezza delle antiche catacombe di San Callisto, nella vecchia cava di pozzolana, c’erano ammassate decine e decine di cadaveri. La notizia non tardò a diffondersi e subito uno spontaneo quanto drammatico corteo di familiari affollò ininterrottamente e per giorni la strada che conduceva a quelle grotte.
Nella prima riunione al Viminale, il governo assume quindi il solenne impegno a erigere sul luogo della vendetta tedesca un monumento a perenne ricordo dei Martiri e di tutti i caduti della guerra di Liberazione». La priorità era -malgrado le tante emergenze di una città devastata dalla guerra- dare degna sepoltura a quei corpi. La decisione fu rapidissima e sbrigativa: murare l’ingresso delle gallerie e trasformare quei cunicoli in una gigantesca tomba comune dove tutte le vittime sarebbero state ricordate. Del resto lo stato di quei poveri resti rimasti lì per mesi e l’impossibilità di riconoscere, una ad una, le tantissime vittime, suggeriva una soluzione del genere. A quel punto però accadde qualcosa.
Ci sono persone normali che fanno qualcosa di eroico e poi ci sono eroi che fanno cose normali, il proprio lavoro talvolta. Era questo il caso del professor Attilio Ascarelli, anatomopatologo e medico legale, che si offrì anzi -letteralmente insistette fino a convincere le autorità- della possibilità di riconoscere ciascuna vittima. Un lavoro immane e dolorosissimo svolto con impegno commovente da Ascarelli che per cinque mesi -da luglio a novembre- ogni giorno, lavorando all’interno delle grotte (se i resti infatti fossero stati portati fuori, con il caldo estivo, sarebbero stati definitivamente compromessi) riuscì a dare a quasi tutti un nome. Un gesto straordinario del quale i familiari e la storia furono grati.
Fu dunque allora che ci si rese conto, anche per le fortissime pressioni dei parenti delle vittime, che non ci si poteva limitare ad una sepoltura: il Paese aveva bisogno di costruire lì un memoriale, un simbolo che non solo ricordasse i martiri ma che diventasse un inno alla libertà. A ben guardare infatti, scorrendo quel drammatico elenco di nomi, c’era tutta Roma: 335 civili presi alla rinfusa tra prigionieri politici ma anche innocenti prelevati notte tempo dalle case. Soldati, giovani, anziani, uomini, donne, cattolici, ebrei, atei e partigiani. Tutti, senza distinzione, accumunati nella tragedia. Rendere loro onore significava ricordare il prezzo che questo Paese aveva pagato prima di tornare libero. Un concorso, questa fu la strada intrapresa. Un concorso di architettura dal quale scaturirà una delle più belle ed importanti opere del secolo scorso e tutto questo malgrado le premesse tutt’altro che incoraggianti. In effetti al momento di decretarne il vincitore, la commissione presieduta da Luigi Piccinato, assegnò la vittoria ex-aequo a due gruppi. Sembrerebbe una scelta salomonica, tipica di quei giochi politici che non vorrebbero scontentare nessuno e, anzi, non ci si limitò a questo, ma fu perfino stabilito che il progetto da realizzare sarebbe stata l’unione delle due proposte. Il rischio di scadere nel grottesco era concreto e invece, per una volta, una commissione illuminata riuscì a favorire un progetto straordinario.
RISORGERE ed UGA questi erano i motti che contraddistinguevano i due gruppi di progettisti vincenti: il primo composto da Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario Fiorentino e lo scultore Francesco Coccia mentre il secondo annoverava Giuseppe Perugini con Uga de Plaisant e Mirko Basaldella. Due compagini, come osserverà brillantemente Aldo Aymonino, assolutamente eterogenee a cominciare dai loro capofila: Mario Fiorentino, di famiglia ebraica ed arrestato in una tipografia clandestina sfuggirà al massacro delle Ardeatine per un mese soltanto e Giuseppe Perugini, nato a Buenos Aires, che aveva risalito la penisola al seguito delle truppe alleate, lavorando nell’Ufficio Tecnico dell’esercito americano per il quale progetterà i cimiteri di guerra di Anzio e Cassino. Per comprendere la portata del loro progetto bisogna per un attimo immaginarsi cos’erano stati fino a quel momento -ed in particolare sotto il regime fascista- i monumenti commemorativi: sacrari magniloquenti che annichilivano con la loro imponenza il visitatore. Ovviamente la prima cosa su cui si concentrarono i progettisti fu proprio prendere le distanze da tutto ciò, intraprendendo una strada del tutto nuova, un’architettura finalmente democratica, solenne e obbligatoriamente anti-retorica.
Una piazza, così si presenta il Mausoleo al visitatore che ha varcato lo stupendo cancello-scultura di Mirko Basaldella posto al cospetto dell’imponente scultura di Coccia che domina uno spazio misurato e, a suo modo, solenne. Lì, in quello slargo in cui le SS spingevano giù dai camion i poveri martiri, si spalanca il buio ingresso alle cave. Un cunicolo scavato nella roccia volutamente lasciato dagli architetti così come appariva quel maledetto 24 marzo del 1944. Il visitatore potrà percorrere dunque gli ultimi passi delle vittime giungendo al luogo dell’eccidio. Il buio delle cave è squarciato da alcune voragini nella roccia che non son altro che il risultato delle bombe naziste fatte esplodere nel maldestro tentativo di nascondere per sempre quell’orrore di cui, persino loro, forse provavano vergogna.
Più che spettatori -per usare ancora le parole di Aymonino- siamo, ancora oggi, dei testimoni di quel massacro, il monumento è una sorta di mappa topografica del dolore e del ricordo. Da lì, dal ventre della terra, un altro percorso conduce all’incredibile aula che accoglie le sepolture delle vittime. Alla natura e ai cunicoli si sostituisce ora l’architettura di uno spazio compresso, geometrico ma emozionante. Le 335 tombe, allineate in ordine drammatico, sono sovrastate da un monolite, un’immane lapide, che accumuna i martiri e ne sottolinea il sacrificio condiviso. All’interno uno spazio sorprendente, severo ma al contempo emozionante, caratterizzato dalla sottile asola di luce che corre lungo tutto il perimetro e che fa apparire il macigno quasi sospeso. Precarietà e solidità si fondono creando un ossimoro statico permesso dalla mirabolante struttura in cemento armato concepita dal genio di Riccardo Morandi.
Il monolite diviene quindi il centro architettonico del progetto ma non del memoriale, che è basato al contrario su rapporti anti-gerarchici. La visita può partire indifferentemente sia dalle gallerie concludendosi nell’aula così come svolgersi sul percorso inverso e il rapporto tra questi due ambienti -volutamente antitetici- viene esaltato ed amplificato; a questo proposito è sorprendente osservare il particolare della superficie del cemento armato trattata con intonaco martellinato in analogia con quella dei cunicoli di pietra.
Raramente nella storia un progetto così importante è stato sottolineato ed onorato da un’architettura altrettanto ispirata, alle Ardeatine invece, sembra che tutti, dai politici ai progettisti, dai parenti agli scultori, abbiano lavorato all’unisono per celebrare la memoria, non solo delle vittime, ma di tutto il Paese. Quasi un secondo Altare della Patria, un’architettura che omaggia il sacrificio che l’Italia ha pagato alla libertà con un monumento che, nel mondo, ancora oggi, ha pochi eguali.
(articolo scritto da Andrea Bentivegna con Danela Tanzj e publicato su La Voce di New York – foto di Flavia Rossi)